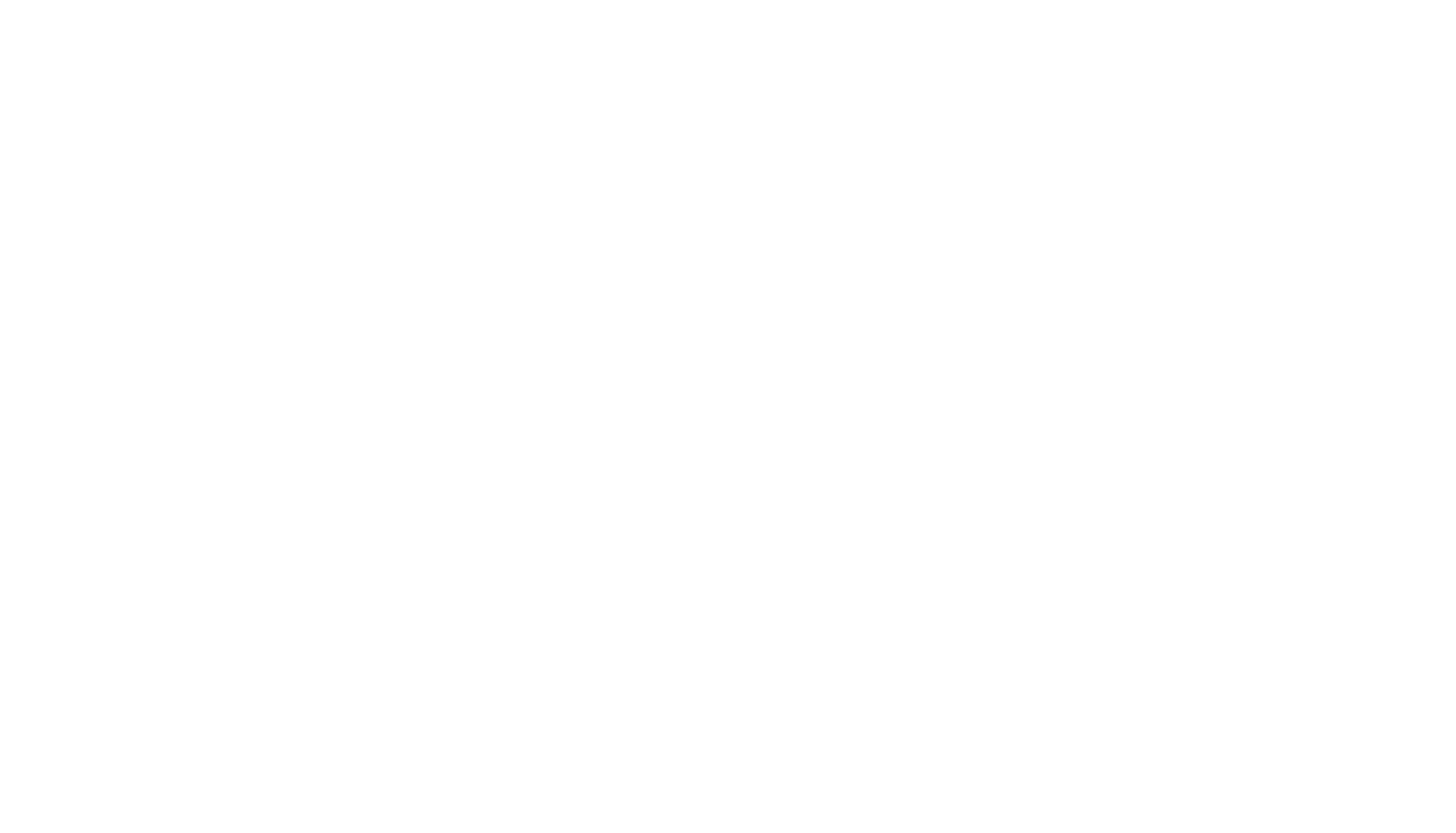La visione capovolta

Ho sempre cercato una sorta di capovolgimento con le cose, con le persone e con tutto ciò che mi circonda. Sono fermamente convinta che attraverso una visione rovesciata si riesca a sfuggire ai consueti e soliti punti di osservazione. Ciò avviene anche con lo studio della pittura, per questo motivo tale ricerca si pone all’origine della mia pratica di scrittura critica che mi piace considerare come un corpo: vivo di stimoli, con nervi sensibili capaci d’immediati riflessi. Attraverso la visione capovolta, in cui vivo, leggo e studio la pittura per ciò che non è, ovverosia il suo inverso o altrimenti opposto, si tratta di un insolito impulso che mi permette di dare a questa materia ulteriori e nuovi significati, facendo emergere inedite suggestioni. A seguire, il passaggio alla scrittura è un necessario atto di volontà, inteso a fare chiarezza, mai tendente a descrivere o eseguire un’analisi cronachistica, piuttosto dedito a quantificare e interpretare i dubbi da schiudere. Inoltre, considerare la fine come elemento d’inizio combacia con il capovolgimento di un’usuale visione che inevitabilmente rompe l’attuale assedio al conformismo di pensiero.
Lo studio etimologico, ritornando all’origine e alla storia delle parole, così come l’evoluzione fonetica, morfologica e semantica, alla pari dell’attenzione verso le minime variazioni è certamente capace di rivelare un inedito racconto dove pensiero, abitudini e sensazioni si attraversano e si fondono. Allora, perché non recuperare questa visione contro l’imposizione e il condizionamento delle normali vedute per invertire l’ordine cronologico dello studio etimologico della parola pittura, sino a cercare di desemantizzarla? Sono certa che il significato semantico del termine è stato alterato da un intimo e profondo dialogo d’indagine che ho intessuto negli anni con alcuni pittori, con i quali mi sono ripetutamente confrontata sullo stato della loro ricerca. Per me tale parola ha già da tempo perso il significato originario che normalmente siamo soliti dare nella lingua italiana, essendo l’elemento primario che orienta i miei studi e letture, diventando il tema dove far convergere tutte le possibili energie e attenzioni. Cosicché alla sola lettura e pronuncia di questa parola si spalanca improvvisamente una felice finestra verso uno spazio colmo di molteplici, libere e sorprendenti visioni.
Eppure, sfogliando il dizionario Treccani il termine pittura trova la seguente declinazione: «Sostantivo femminile. L’arte di dipingere, raffigurando il mondo esterno, o esprimendo l’intuizione fantastica, per mezzo di linee, colori, masse, valori e toni».
https://www.treccani.it/vocabolario/pittura

Inoltre, si afferma che pittura deriva dal latino pictūra, quindi immagino che la sua flessione da nome in aggettivo e verbo si sia resa necessaria a causa della sua costante presenza nella storia dell’uomo e al contempo dall’esigenza di intensificarne la comunicazione. Volendo continuare a capovolgere i consueti orientamenti di lettura, perché non domandarsi cosa sia oggi la pittura, anziché analizzare l’origine latina del termine. Il pittore Ruggero Savinio considerava questo interrogativo l’equivalente dal domandarsi come è fatta la pittura?
(Ruggero Savinio, Il senso della pittura, Biblioteca Neri Pozza, Vicenza, 2019, p. 9)
Da qui si apre la questione circa l’apprezzabile diversità tecnica che la caratterizza: un insieme di mezzi espressivi unificati a manifestare una particolare condizione.
Secondo il filosofo Gilles Deleuze il vero pittore è colui che, oltre ad essere sempre severo e critico con sé stesso, deve aver attraversato durante la sua carriera almeno una tempesta emotiva che lo abbia condotto a discostarsi dai normali schemi e metodi espressivi.
Gilles Deleuze, Sulla pittura, corsi marzo-giugno 1981, a cura di David Lapoujade, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2024, p. 31
Tale forma di tensione deriva da un particolare antagonismo che si crea tra l’occhio e la mano, ma non rende affatto conto delle teorie della percezione bensì dello stato umorale del creatore. Questo perpetuo stato d’impazienza è la condizione necessaria sufficiente che conduce il pittore a non essere rilassato, bensì mosso e quasi compresso in una perenne condizione d’inquieta ricerca. Tant’è che l’origine di un’opera coincide spesso con la presa di coscienza e la definizione dell’inizio di una difficoltà, ed è proprio lì che la mano libera si muove senza limiti, segnando e tracciando coordinate visive e scenari.
Ritornando al termine latino pingendi ars (arte del dipingere) è tale la manifestazione fisica del fare pittorico a prescindere dalle specifiche del supporto sia esso tela, carta, muro o tavola. Piuttosto, quest’ultimo è da considerare come un sistema aperto che racchiude diverse questioni nel rapporto tra l’artista e le complesse variabili quali lo spazio, i toni, la luce e il tempo. Quanto affiora alla fine può essere un soggetto figurativo tracciato nell’immediatezza dell’attimo, altrimenti fatto emergere con la cura del tempo e la pacatezza di toni e tratti. Eppure, in entrambi i casi è una chiara e inequivocabile risposta all’essenziale domanda che la pittura pone direttamente all’artista: chi sei tu che dipingi? La ragione di questa pratica diventa l’origine di un mondo, che alla pari di un viaggio interminabile brucia ardentemente del suo significato poetico, della forma di una conoscenza, della visione di un sogno o di una passione.

Pittura è anche strettamente collegata all’aggettivo greco ποικίλος (poicolos), che indica un concetto verbale e visivo complesso la cui forma è ingegnosamente bella.
Perciò inevitabilmente ci troviamo a sfiorare la questione del bello, al punto da domandarci se anche la forma espressa in pittura debba essere inevitabilmente così. E allora come risolvere la tensione tra la mano e la visione dell’occhio. Deve esserci un punto di equilibrio per originare un dipinto?

Sì, l’opera pittorica, germogliando da questioni ben più profonde, svela conoscenze e aperture verso nuovi significati che non si prospettano immediati per chiarezza e facilità d’intuito, ed è proprio in questa necessaria elaborazione che si potrà riconoscere il bello. Pertanto, una bella pittura è qualsiasi opera generata da una mano libera, priva di sottomissioni, creata nel rovesciamento degli ordini e delle consuete visioni. E ancora, il verbo pingĕre ovvero dipingere, il cui participio è pictus si rivela come forma derivante dal verbo pungere, ovvero segnare, fissare dei punti visuali di una proiezione attraverso linee, colori e studi di composizione. Ed è lì, in quegli studi che risiede il germe di un essenziale caos che non inghiottisce tutto, bensì spalanca al nudo, vero, sincero e intramontabile incanto della creazione pittorica.
Chi è Maria Vittoria Pinotti?

Maria Vittoria Pinotti (San Benedetto del Tronto) è storica dell’arte, autrice e critica indipendente. Dal 2016 riveste il ruolo di Gallery Manager in uno spazio d’arte contemporanea nel centro storico di Roma. Ha lavorato con uffici ministeriali, quali il Segretariato Generale del Ministero della Cultura e l’Archivio Centrale dello Stato.
Attualmente collabora con riviste del settore culturale concentrandosi su approfondimenti tematici dedicati all’arte moderna e contemporanea.