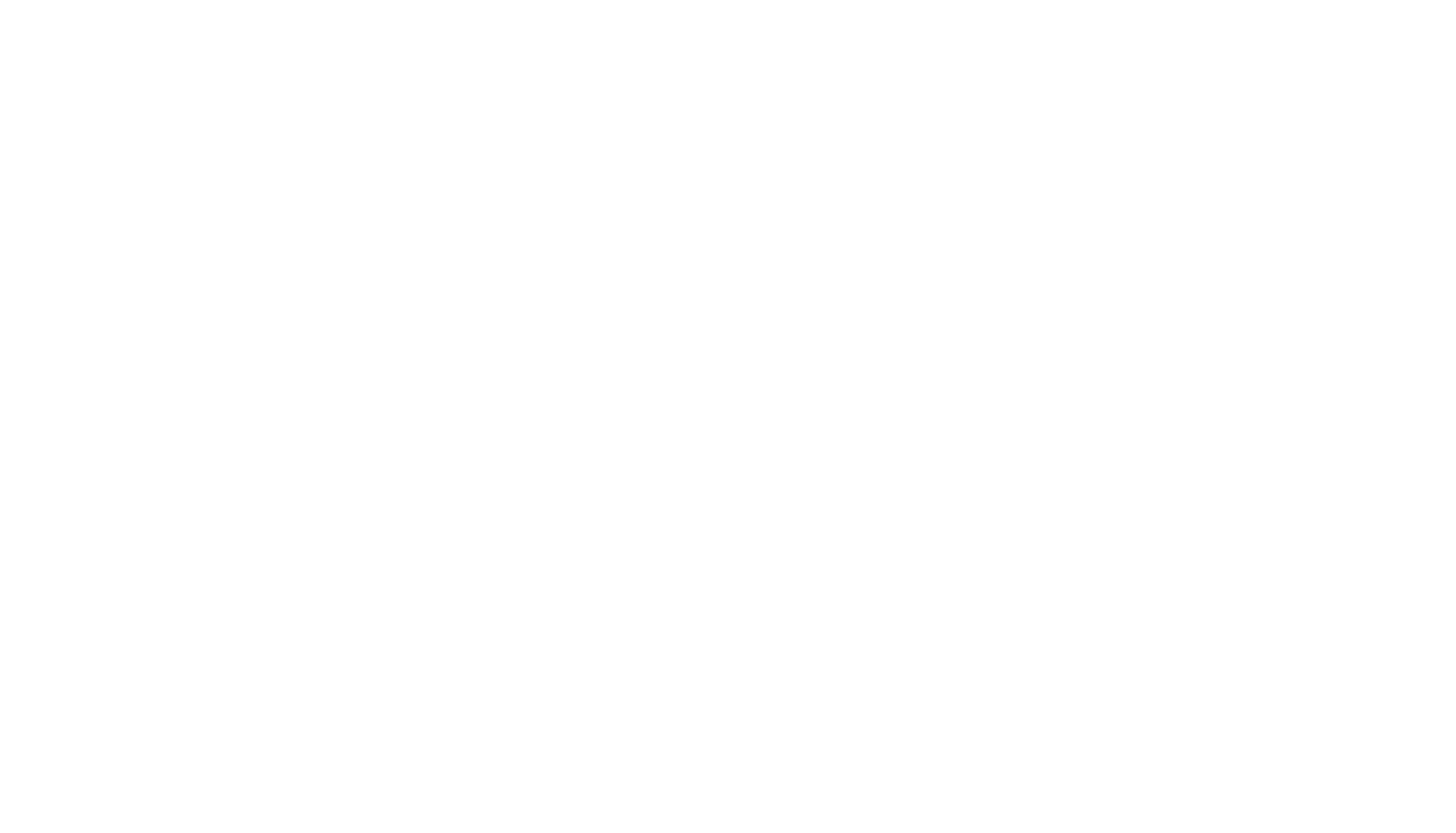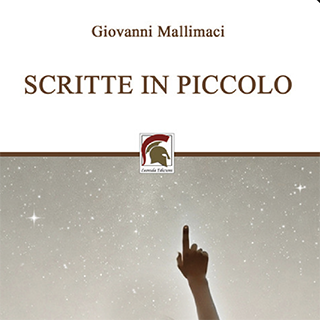Un libro di
— Giovanni Mallimaci

Il tuo libro esplora temi profondamente umani, come l’io interiore,
l’amore e la società. Qual è stata la motivazione principale che ti ha spinto
a scrivere quest’opera?
Questo libro nasce da una necessità profonda, un bisogno irrefrenabile di mettere per iscritto ciò che sentivo dentro. È stato inizialmente un atto intimo, personale, ma poi mi sono reso conto che ciò che stavo vivendo non era soltanto mio. Fondamentalmente, siamo tutti umani, siamo tutti gli stessi, e ciò che affrontiamo in solitudine è spesso condiviso da tanti altri, anche se non lo mostrano.
Viviamo in un’epoca in cui sembra che siamo sempre più connessi, sempre più vicini, ma in realtà ci stiamo perdendo. Ogni giorno, nascondiamo il nostro vero io dietro maschere lucenti, splendenti, costruite per gli altri. Ci presentiamo al mondo con un’immagine perfetta, filtrata, distante da chi siamo realmente. In questo processo, ci dimentichiamo di guardarci dentro, di riconoscere noi stessi. E così, giorno dopo giorno, ci allontaniamo dalla verità.
La verità, però, non si può ignorare per sempre. A un certo punto, emerge, bussa alla porta della nostra coscienza e ci chiede di essere ascoltata. Questo libro è nato da quel richiamo, da quella necessità di autenticità che sentivo dentro di me e che non potevo più ignorare. È una risposta a un mondo in cui la realtà sembra essersi dissolta, lasciando spazio solo alle apparenze.
Scrivere questo libro è stato un atto di ribellione contro questa tendenza. Ho voluto creare qualcosa che fosse vero, autentico, reale. Questo libro è, in sostanza, un inno all’essere veri, all’essere sinceri, prima di tutto con se stessi. Perché solo quando siamo onesti con noi stessi possiamo esserlo con gli altri. E solo attraverso questa sincerità possiamo ritrovare la luce, quella luce vera e profonda che ci guida verso chi siamo veramente. Ma c’è un altro motivo, altrettanto importante, che mi ha spinto a scrivere questo libro. Volevo far capire a chiunque lo legga che non siamo soli. Quello che affrontiamo, le difficoltà, le paure, le sofferenze, non sono solo nostre. Spesso ci guardiamo intorno e vediamo gli altri vivere vite apparentemente perfette, felici, senza ombre. Ci dimentichiamo che quelle maschere lucenti, quegli sguardi sereni, nascondono spesso le stesse fragilità, gli stessi dolori che portiamo dentro di noi.
Essere vulnerabili non è un male. Essere sensibili non è una debolezza. Sono, invece, i pilastri su cui si costruisce la sincerità. Solo attraverso la vulnerabilità possiamo essere veri, autentici, reali. E solo essendo veri con noi stessi possiamo esserlo con gli altri. È attraverso la sensibilità che creiamo uno spazio per l’amore, e senza amore tutto il resto perde significato. Senza amore, siamo niente.
Questo libro vuole ricordarci che c’è luce, anche nei momenti più bui. Vuole invitare chi legge a guardarsi dentro, a togliersi la maschera e ad accettare se stesso. Perché la verità non è qualcosa da temere, ma qualcosa da abbracciare.Viviamo in un’epoca in cui siamo sempre più social, sempre più concentrati sul “mostrare” agli altri, mentre ci dimentichiamo di guardarci davvero. E questa è la vera tragedia. Stiamo perdendo il contatto con la nostra essenza, con la realtà dei fatti. Ma io credo che possiamo tornare a essere veri. Possiamo tornare a vivere con sincerità, partendo da noi stessi.
Questo libro è il mio invito, il mio contributo, il mio messaggio. È un inno alla verità, alla sensibilità, e soprattutto all’amore, che è il cuore di tutto.
In che modo il tuo stile di scrittura si distingue da quello della poesia classica, e quali elementi innovativi e originali hai integrato nel tuo lavoro?
Quando parlo di poesia, di scrittura classica, la mia mente va subito a pensare a figure come Montale, Pirandello, Foscolo: poeti che andavano alla ricerca della parola più adatta, della forma più perfetta. Erano persone che hanno studiato, che hanno costruito la loro persona e la loro fortuna attorno alla poesia. Gente che con la poesia ci viveva. Ma, quella poesia che loro scrivevano, era sempre la poesia classica, quella con lo stile ben radicato, quello che tutti conosciamo. Io, però, anche se parlo molto in modo poetico, non mi ritrovo in quella poesia. Parlo di poesia, è vero, ma non è quella classica. La poesia che intendo io è quella che si nasconde dietro ogni elemento della vita. E questa, secondo me, è un’altra cosa.
Perché si distingue? Perché il lavoro che facevano quei grandi poeti, e che ancora oggi tanti fanno, è un lavoro mirato, totalmente indirizzato a trovare il modo poetico perfetto, a cercare la poesia, la parola giusta, la scrittura migliore. Io non ho fatto questo. Ho fatto un’altra cosa, parallela ma diversa. Quello che ho fatto io è stato spogliarmi di una maschera, ma anche involontariamente. Non ho mai preso, in tutto il corso di questi scritti, un’idea preconcetta di poesia. E infatti c’è un motivo per cui li chiamo scritti e non poesie. La poesia, nel mio caso, è stato uno strumento che ho usato per rendere omaggio, nel modo più sincero possibile, a quei momenti che volevo raccontare. Era lo strumento che mi serviva per far capire, nella maniera più profonda, ciò che stavo vivendo e ciò che sentivo.
La poesia, per me, è stata un mezzo per far capire a chi avrebbe letto, ma anche a me stesso, ciò che davvero stavo provando. C’era bisogno di un modo forte per descrivere queste sensazioni, non di un modo banale. E poi, se mi chiedete perché sia innovativo, sinceramente non so rispondere. Quello che posso dire è che quello che ho fatto è spoglio di qualsiasi scopo lucrativo. Non c’è niente in ciò che scrivo che abbia il fine di guadagnare consensi o approvazione. È stato solo un atto di verità, nient’altro.
Forse, se proprio vogliamo parlare di innovazione, posso dire che quello che caratterizza i miei scritti è proprio la loro natura. Perché anche le parti più lontane dalla poesia, magari le prefazioni o i passaggi meno poetici, ti fanno capire che non stai leggendo delle poesie nel senso tradizionale del termine. Quello che stai leggendo sono racconti, sono strascichi di esperienze, sono sofferenze, gioie, e pene. Mentre leggi, ti rendi conto di star vivendo con quello che leggi, di averlo già vissuto, perché quelle parole non sono lontane, non sono alte, non sono irraggiungibili. Quando leggi una poesia classica, è facile che ti sembri qualcosa di distante, quasi superbo, difficile da afferrare davvero. Nel mio caso, invece, ho scelto un linguaggio più diretto, più vicino al lettore. Perché il mio intento era che chi leggesse potesse riconoscersi, immedesimarsi, entrare in quella realtà. Se avessi scelto uno stile di poesia troppo alto, rischiavo di non far arrivare il messaggio. E, infatti, penso che ci siano anche racconti che non tutti capiranno allo stesso modo. Ognuno, leggendo, troverà ciò che più gli è vicino. E questo è il senso: che il lettore possa prendere quello che gli serve, che possa trovare in questi scritti qualcosa di suo. Non credo che una persona possa ritrovarsi in ogni singolo scritto, ma sono certo che in almeno uno di essi si riconoscerà.
In fondo, il libro che ho scritto è un ritrovo per se stessi. Se avessi usato una poesia classica, penso che questo non sarebbe successo. E, per far sì che il lettore si immedesimi davvero, ho sempre detto che bisogna leggere con il proprio “bambino interiore”, con quella parte di sé che è pura, che non ha filtri, che è in grado di sentire senza sovrastrutture. Perché se leggi questo libro con l’adulto che si crede grande, forte, e impassibile, non riuscirai a coglierne il senso e sprecherai solo tempo.
In che modo essa ti ha permesso di “dare profondità e verità” ai tuoi testi? Quali tecniche specifiche hai trovato particolarmente utili per arricchire la tua espressione artistica?
Come ho detto in precedenza, se avessi scelto uno stile preciso, mirato, sarebbe diventata poesia classica. Invece, ho deciso di adottare uno stile più diretto, più terreno. Se avessi optato per uno stile più definito e formale, avrei perso quella genuinità, quella sorta di verità che rende autentici i momenti che volevo descrivere. Sarebbe stato in contrasto con ciò che avevo in mente per il libro e con il messaggio che volevo trasmettere. Perciò, non si può dire che ci sia uno stile preciso in senso stretto.
Tuttavia, questo non significa che io non sia consapevole di ciò che sto facendo. La mia scrittura poetica, infatti, è frutto di una scelta precisa, di un lavoro consapevole. C’è sicuramente un legame con il fatto che la poesia deve essere pura, autentica, legata al momento in cui nasce. Ma c’è anche una verità più profonda, che sento dentro di me, qualcosa che so di cercare mentre scrivo, e che è diventato ancora più evidente quando ho iniziato a pensare che questo potesse davvero diventare un libro. Mentre trascrivevo quei momenti, li ho mantenuti puri, ma allo stesso tempo ho cercato di conferire loro un senso poetico, di migliorarli, rendendoli ancora più ricchi. Questo è stato un lavoro consapevole, non un atto casuale. Non sono un genio, ma ho dedicato attenzione a ogni parola, cercando di renderla il più precisa possibile.
Se parliamo di uno stile, allora si può dire che ci sono state delle influenze. In particolare, quella scolastica. Questo libro è stato scritto durante un periodo in cui stavo approfondendo molti temi e autori italiani, proprio mentre finivo il quinto superiore, e alcuni scritti sono nati anche dopo aver terminato la scuola. C’era una freschezza culturale, una conoscenza poetica che mi ha permesso di esprimere i miei pensieri con maggiore lucidità. A quel tempo, se mi avessero parlato di alcuni autori, avrei saputo rispondere con sicurezza. La scuola, pur con la sua visione molto basica e talvolta scolastica della poesia, mi ha aiutato a dare forma ai miei pensieri, a trasmetterli con maggiore chiarezza
Quindi, se devo individuare uno stile, posso dire che c’è un’influenza che arriva dalla scuola, ma anche dai poeti che più ammiro. Come ho accennato, c’è un po’ di Montale nel mio stile, e anche un richiamo alla scrittura di Foscolo e Pavese, poeti che non ho studiato a fondo durante il periodo scolastico, ma che ho avuto modo di recuperare autonomamente in seguito. Queste influenze si mescolano con quella che è stata l’influenza della mia professoressa di italiano Dominella Lipari, che ha saputo trasmettermi una passione sincera per la poesia.
In definitiva, questo “stile” è il risultato di una fusione tra gli insegnamenti scolastici, la cultura poetica che ho assorbito in quegli anni e l’influenza di autori che mi hanno guidato nella scrittura. È uno stile che nasce dalla riflessione e dalla ricerca, ma che, pur rimanendo consapevole di queste influenze, cerca di mantenere la sua autenticità, la sua verità.
“Scritte in piccolo” si presenta come una denuncia nei confronti delle menzogne della società moderna e come un richiamo alla riscoperta dell’autenticità. Quali spunti di riflessione speri che i lettori possano trarre dai tuoi versi e quali messaggi chiave desideri trasmettere a coloro che si avvicinano alla tua opera?
Il percorso che ho affrontato, sia personale che artistico, è stato un processo intenso, fatto di dettagli, incontri e momenti che hanno contribuito a creare un’opera radicata profondamente nell’autenticità. Ogni esperienza, grande o piccola, ha avuto un ruolo fondamentale, e il libro che ho scritto riflette proprio questo: non c’è nulla di marginale, nulla di insignificante, perché ogni frammento della quotidianità ha avuto il suo peso nel definirmi.
La mia insegnante di recitazione, Beatrice Pelliccia, è stata una figura centrale in questo percorso. Tra i 16 e i 18 anni, un’età in cui si cresce in maniera incredibile attraverso il processo di imitazione, lei mi ha insegnato a non chiudere la porta al mio “bambino interiore”, come direbbe Pascoli. Quella porta non è spalancata, ma rimane socchiusa, e questo mi ha permesso di mantenere una connessione con la mia parte più autentica. Se mia madre mi ha donato una sensibilità naturale, Beatrice l’ha espansa, facendola sbocciare, trasformandola in qualcosa che potevo usare per comunicare ed esprimermi.
Questo approccio mi ha influenzato profondamente, anche nella scrittura di questo libro. Non c’è uno stile narrativo predefinito, né una struttura preparata a tavolino. Sarebbe stato un libro diverso, altrimenti. È un’opera scritta “alla mano”, partendo da ciò che sentivo e cercando di tradurlo in parole. La vera difficoltà non è stata trovare i termini giusti o costruire le poesie, ma fare tutto questo nella sua semplicità. Denudarmi, metaforicamente parlando, è stato il passaggio più complesso. Sapevo che l’unico modo perché il libro avesse senso era essere completamente sincero, senza maschere, e questo significava mostrare una vulnerabilità che non sempre è facile accettare.
I momenti di consapevolezza più profonda mi hanno aiutato molto nella scrittura. Non sono sempre come appaio in quelle pagine, non sempre così sensibile e vulnerabile. Quello che ho scritto rappresenta istanti, schegge di verità in cui mi sono sentito davvero così. Non potrei esserlo continuamente, ma è proprio questo, secondo me, il punto forte del libro: raccoglie quei frammenti rari, quei momenti che lasciano emergere ciò che spesso rimane nascosto.
Anche a livello di esperienze personali, tutto è stato importante. Non solo gli eventi “grandi” o “decisivi”, ma anche i dettagli quotidiani, le piccole cose che spesso diamo per scontate. Ogni esperienza, più o meno intensa, più o meno leggera, ha contribuito al risultato finale. Non c’è una gerarchia tra le esperienze: ogni momento ha avuto il suo peso, e nel complesso tutto è stato radicale.
Ciò che volevo far arrivare era una genuinità totale. E non è facile esserlo, soprattutto in una società che, col tempo, sembra vivere sempre di più in un tempo e uno spazio bidimensionali. Diventa difficile riconoscersi, e ancora più difficile riconoscere chi si ha davanti. Questo libro, invece, è nato per opporsi a quella bidimensionalità, per celebrare la complessità dei dettagli e la profondità delle emozioni, e per ricordarci che dietro ogni frammento, ogni momento, si cela una verità che merita di essere raccontata.
Nel tuo libro,conduci il lettore in un viaggio attraverso la vulnerabilità e la sensibilità.
Come ti sei preparato emotivamente per affrontare questi argomenti complessi e quali esperienze personali hai ritenuto più significative durante il processo di scrittura?
Entrando nell’ultima domanda, mi rendo conto che queste cinque domande toccano davvero ogni punto fondamentale di questo libro e di ciò che voglio trasmettere. Devo quindi fare i miei complimenti, perché queste domande riescono a raccogliere perfettamente tutti gli aspetti principali di ciò che ho scritto. Ora, sono pronto a rispondere all’ultima domanda, che rappresenta la sintesi finale di tutto il lavoro.
A questo punto, voglio parlare di un aspetto importante del libro che arriva nella sua parte finale. Lì, in modo deciso, dico che non voglio che il lettore legga il mio libro con un approccio metodico o predefinito. Ho scelto di non rivelare certi concetti all’inizio proprio per evitare che il lettore iniziasse a leggere con delle aspettative già formate, con la sensazione di dover seguire un “modo” di leggere, di “dover” provare certe emozioni o riflessioni. Se avessi introdotto queste idee all’inizio, il lettore avrebbe letto in modo troppo razionale, cercando di decifrare ogni parola con una metodologia impostata. Invece, il mio obiettivo era che leggesse liberamente, senza filtri, senza sentirsi costretto a vivere determinate emozioni o a capire immediatamente tutto. Volevo che il lettore si lasciasse travolgere da ciò che leggevano, senza troppe preoccupazioni. Che leggesse con apertura, e solo alla fine scoprisse una visione più completa.
Sinceramente, non credo che un libro come questo possa cambiare radicalmente una persona. Non penso che basti una sola lettura, un film o un’opera per trasformare qualcuno in modo profondo e definitivo. Certo, un libro può stimolare riflessioni e ispirare, ma cambiare una persona richiede molto più di una singola azione. Quando si parla di cambiamento positivo, di fare qualcosa di bello, non basta poco. Serve impegno, dedizione, perseveranza. Si tratta di un lavoro che dura nel tempo, che cresce passo dopo passo. Al contrario, con poco si può distruggere tanto. È facile abbattere, demolire, annientare qualcosa con pochi gesti, ma costruire, migliorare, richiede molto più tempo e sforzo. Il “poco” e il “molto” non vanno mai nella stessa frase quando parliamo di costruire qualcosa di positivo. Solo per distruggere, bastano pochi attimi. Ma per costruire qualcosa che duri, serve ben altro.
Ciò che spero davvero che il lettore porti via da questo libro è una riflessione che può sembrare semplice, ma che ha un grande valore: mi piacerebbe che, anche a distanza di anni, chi ha letto queste pagine si ricordi almeno di un dettaglio, di una riflessione che gli ha fatto pensare. Se anche solo una piccola frase potesse rimanere impressa nella mente di qualcuno, per me sarebbe già una vittoria. Spero anche che questo libro possa rincuorare chi lo legge. Perché, come ho detto più volte, non siamo soli nei nostri problemi. Essere autentici, conoscere se stessi e non giudicare gli altri sono valori fondamentali, perché alla fine ognuno ha la sua storia e le sue difficoltà. La bellezza della vita sta proprio nella diversità delle esperienze, e proprio questa diversità ci unisce, ci rende uguali.
Voglio anche essere chiaro su un altro punto, che emerge anche nel libro: questo è anche un messaggio di denuncia, rivolto alla generazione più anziana, quella che ancora detiene il potere. Troppo spesso, questa generazione non punta sui giovani. Si accusa la nostra generazione di non fare abbastanza, ma, per quanto la colpa possa essere a volte nostra, la realtà è che a volte manca il supporto e l’opportunità. Questo libro vuole essere un invito a chi è più grande a guardare ai giovani non come una minaccia, ma come una risorsa. Abbiamo tante idee, tanta forza, tanto potenziale. Ma ci serve qualcuno che creda in noi. La vera domanda è: chi avrà il coraggio di darci quella possibilità? Chi avrà il coraggio di ascoltarci, di permetterci di esprimerci su una scena più grande? La generazione più anziana deve essere pronta a fare un passo indietro e a dare spazio. Non basta accusarci di non fare abbastanza, bisogna darci gli strumenti per farlo.
Il messaggio centrale di questo libro, come ho già detto, è stato affrontato durante l’intervista, ma voglio approfondirlo. Penso che vada diviso in due dimensioni: quella più razionale, che è il messaggio diretto del libro, e quella più personale, che riguarda ciò che davvero desidero come autore. Da un lato, voglio che il lettore comprenda il valore dei temi che propongo. Dall’altro, mi auguro che chi legga si accorga di me, anche se non lo dico per egoismo. Non mi interessa la fama, ma spero che chi legge capisca che anche un ragazzo di 18 anni può scrivere con passione, con sincerità, con forza. Non sono un genio, non sono qualcuno di straordinario. Ma sono un giovane che ci crede davvero, che ha messo nel libro tutta la sua forza e il suo impegno, come tanti altri. Se una persona, dopo aver letto, si accorge che noi giovani siamo capaci di cose grandi, che abbiamo la forza per cambiarle, allora questo per me sarebbe un grande risultato. Ma per fare davvero la differenza, bisogna che ci siano delle opportunità concrete. Serve qualcuno che investa su di noi, che ci dia la possibilità di crescere e di esprimerci al massimo delle nostre potenzialità.
Se non capiamo questo, se non capiamo che le idee migliori moriranno se non vengono supportate, allora avremo sprecato un’enorme occasione. E sarebbe un peccato. Perché noi giovani siamo forza, siamo luce. Ma da soli, non possiamo fare nulla. Questa luce ha bisogno di essere riconosciuta, accolta, alimentata. Ma la domanda resta: chi avrà il coraggio di farlo? Chi avrà il coraggio di darci la possibilità di brillare? Se non c’è qualcuno disposto a farlo, questa luce finirà per spegnersi, prima di aver avuto la chance di illuminare davvero. E se non saremo noi a farcela, perderemo una generazione con un gran potenziale che merita solo di essere ascoltata e valorizzata.
Chi è Giovanni Mallimaci?

Giovanni Mallimaci è uno scrittore con una profonda vocazione per la narrazione e la riflessione personale, coltivata fin dall’età di 14 anni. La sua formazione artistica ha subito una significativa evoluzione grazie all’incontro con Beatrice Pelliccia, un’insegnante di recitazione che applica il metodo Susan Batson. Questo approccio lo ha portato ad approfondire la sua comprensione delle emozioni umane, trasformando la scrittura in uno strumento essenziale sia per il suo lavoro di attore che per la sua crescita personale.
Un momento cruciale nella sua carriera è stata la partecipazione al progetto “La voce della tua generazione”, un podcast promosso da Samsung, che ha rafforzato la sua fiducia e la sua passione per la scrittura. Mallimaci esplora temi universali come l’io interiore, l’amore, la famiglia, la società e la natura, offrendo una riflessione profonda sulla realtà contemporanea e sulla condizione della sua generazione.
Attraverso la sua arte, Mallimaci invita a riscoprire la vulnerabilità e l’autenticità, sostenendo che essere artisti significa vivere intensamente e riconoscere la bellezza nei dettagli quotidiani. Con il suo approccio sensibile e attento, mira a ispirare gli altri a entrare in contatto con le proprie emozioni e a guardare più a fondo nella propria esistenza.